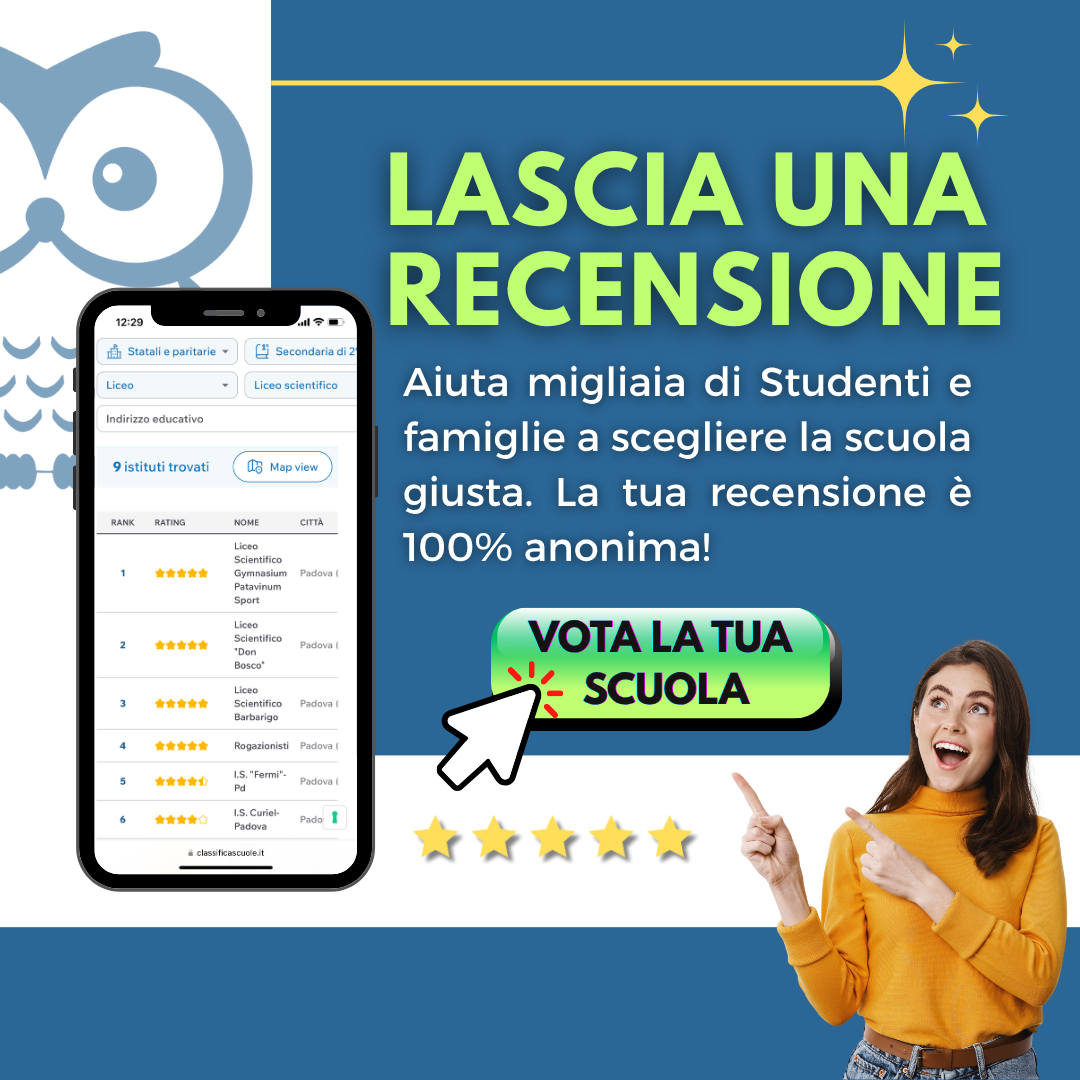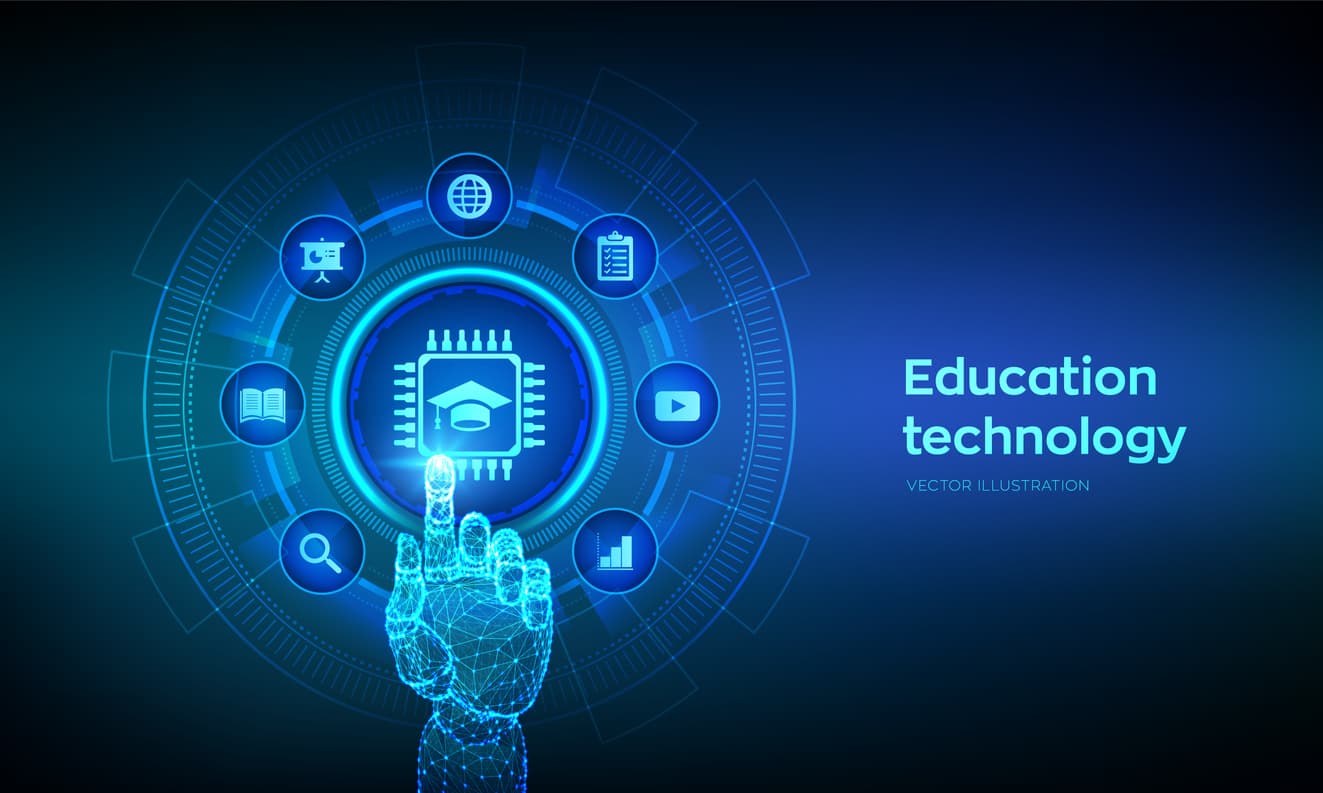Dietro le quinte della leadership educativa italiana
Quando pensiamo al preside di una scuola, l'immagine che emerge è spesso quella di una figura autoritaria, seduta dietro una scrivania, che governa con polso fermo l'istituto. Ma la realtà del dirigente scolastico italiano è ben diversa e decisamente più complessa di quanto si possa immaginare.
Un lavoro che va oltre l'immaginario collettivo
Lavorare anche 10 o 11 ore al giorno, compresi sabato e domenica nei periodi più intensi. Essere il punto di riferimento per centinaia, se non migliaia di persone tra studenti, famiglie e docenti, spesso distribuiti su più edifici scolastici. Gestire un team che non si può scegliere e fare i conti con risorse economiche non sempre adeguate agli obiettivi da raggiungere.
Questa è la fotografia realistica del lavoro del dirigente scolastico italiano, una professione che nell'immaginario collettivo rappresenta il vertice dell'organizzazione scolastica ma che, in realtà, non dispone di tutto il potere che comunemente le si attribuisce.
Il "non potere" dei presidi italiani
"Il dirigente è una persona che gestisce, che organizza, che dà linee di indirizzo", afferma Cristina Costarelli, dirigente scolastica e presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. Una definizione che ridimensiona il concetto di "potere" tradizionalmente associato alla figura del preside.
Il ruolo del dirigente scolastico si configura piuttosto come quello di un coordinatore visionario: "È un trasmettere la propria visione della scuola, gli obiettivi che vuole raggiungere nell'istituto che gli è assegnato, condividerli e fare in modo che l'intera comunità - dal personale interno agli studenti e alle famiglie - vada in quella direzione".
La peculiarità italiana: non poter scegliere la propria squadra
Una delle limitazioni più significative per i dirigenti scolastici italiani è l'impossibilità di selezionare il personale docente con cui lavorare. "Una caratteristica peculiare dell'Italia", spiega Costarelli, che sottolinea come "in tutti gli altri paesi che nella mia carriera ho visitato grazie al programma Erasmus, i dirigenti scolastici hanno la possibilità di scegliere i propri docenti".
Questa limitazione rappresenta un ostacolo non indifferente: se un dirigente ha una certa visione di scuola, per realizzarla avrebbe bisogno di personale che la condivida. Invece, deve lavorare con chi gli viene assegnato, esercitando la propria leadership attraverso la persuasione e la capacità di coinvolgimento piuttosto che attraverso la selezione diretta del team.
Le risorse: l'eterna questione economica
Un altro freno alle iniziative dei dirigenti è rappresentato dalla cronica insufficienza delle risorse economiche. Pur essendo aumentate negli ultimi anni, i fondi attribuiti dallo Stato risultano nella maggior parte dei casi inadeguati per raggiungere obiettivi ambiziosi.
"Non perché il preside debba essere assimilato a un dirigente aziendale", chiarisce Costarelli, "però è ovvio che per realizzare un obiettivo comune ci vogliono persone e risorse materiali". Una constatazione che evidenzia il paradosso di chi deve gestire un'organizzazione complessa con mezzi limitati.
La gestione delle persone: collaborazione e criticità
Come in ogni ambiente lavorativo, anche nella scuola esistono situazioni problematiche da gestire. Tra queste, alcuni comportamenti che sfruttano in modo discutibile le tutele di legge.
Costarelli cita l'esempio di chi utilizza i giorni di permesso previsti dalla Legge 104 per l'assistenza a persone con disabilità concentrandoli strategicamente prima e dopo le pause scolastiche: "Vedere associare i giorni esattamente prima e dopo la chiusura delle vacanze fa un po' pensare. Non si hanno mai le prove che sia un abuso, quindi lungi da me volerlo sostenere, però è una consuetudine che tra i colleghi viene riportata spesso".
La strategia adottata dai dirigenti in questi casi punta sulla responsabilizzazione, anche se non sempre con successo. Un equilibrio delicato tra il rispetto dei diritti dei lavoratori e la necessità di garantire il funzionamento ottimale dell'istituto.
Una giornata tipo: lunga, intensa e mai uguale
"Raccontare la giornata di un preside è molto difficile", osserva Costarelli, "perché se c'è una cosa che non appartiene a questa professione è la consuetudine e la routine".
La mattinata è generalmente dedicata alle attività in corso: assistenza alla segreteria, questioni riguardanti docenti, studenti e famiglie, presenza nell'edificio scolastico. Il pomeriggio è riservato al lavoro di riflessione e pianificazione: circolari, documenti, analisi, decisioni strategiche.
Un lavoro che frequentemente si prolunga fino al tardo pomeriggio, a volte anche la sera. "Realisticamente, volendo dare un numero medio di ore, le 8 della giornata lavorativa si superano ampiamente, si arriva anche alle 10, alle 11 ore", conferma la presidente dell'ANP Lazio.
Quando emergono problemi urgenti, non è raro lavorare nel weekend. È un'occupazione che non ha nulla dell'impiego impiegatizio standard, con le sue 36 ore settimanali ben delimitate. Il rovescio della medaglia? Una varietà continua che mantiene vivo l'interesse e la motivazione: "È un lavoro dove l'abitudine non esisterà mai", conclude Costarelli con una nota positiva.
La sfida dei plessi multipli
La complessità aumenta ulteriormente quando un dirigente deve amministrare contemporaneamente due o più sedi scolastiche territorialmente separate, situazione frequente soprattutto nei territori meno popolosi.
"Il discorso delle scuole con più plessi è inversamente proporzionale alla popolosità del territorio", spiega Costarelli. "Quando ci si allontana dalle grandi città e si raggiungono territori meno popolosi, aumentano i plessi e diminuiscono gli alunni".
In questi casi, la delega diventa fondamentale: il dirigente assicura una presenza a rotazione nei vari plessi e si affida a referenti fidati a cui delegare alcune funzioni. "Questa è ovviamente l'unica strada", conclude la dirigente.
Una professione non per tutti
Nel sistema scolastico italiano, per i docenti non esistono altre possibilità di reale progressione di carriera se non diventare dirigente scolastico. Tuttavia, rispetto al ruolo dell'insegnante, le competenze richieste, l'impegno e le responsabilità aumentano in modo esponenziale, senza un corrispondente incremento proporzionale del trattamento economico.
Nonostante le difficoltà, Cristina Costarelli non esita a consigliare questa carriera alle nuove generazioni: "Sì, lo consiglierei, tant'è che l'ho anche fatto". Ma con una clausola importante: solo a chi se la sente davvero.
Il futuro della leadership scolastica
Le sfide che i dirigenti scolastici devono affrontare sono destinate ad aumentare in un contesto educativo in continua evoluzione. La digitalizzazione, le nuove metodologie didattiche, l'inclusione, la gestione delle emergenze sono solo alcuni dei temi che richiedono una leadership sempre più preparata e flessibile.
Eppure, nonostante tutto, il ruolo del dirigente scolastico rimane fondamentale per garantire la qualità dell'offerta formativa e il benessere dell'intera comunità educante. È una professione che richiede passione, dedizione e una solida capacità di visione strategica.
Per chi sta considerando questa carriera, o semplicemente vuole comprendere meglio chi guida le nostre scuole, è importante avere un quadro realistico: il dirigente scolastico non è un capo onnipotente, ma un coordinatore, un mediatore, un visionario che ogni giorno lavora per far funzionare una macchina complessa con risorse limitate e responsabilità illimitate.
E forse è proprio questa sfida continua, questa possibilità di incidere concretamente sul futuro di centinaia di giovani, che rende questa professione così speciale e, per chi la sceglie consapevolmente, così gratificante.
Articolo a cura di Classifica Scuole - La piattaforma che aiuta studenti e famiglie a orientarsi nel mondo della formazione italiana